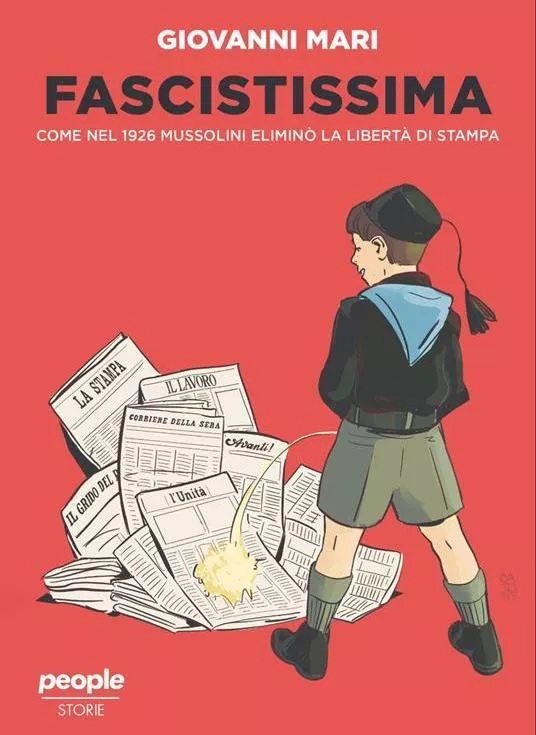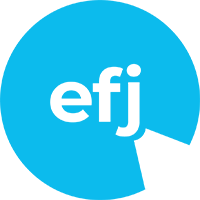Giornalisti, la Corte d'appello di Roma conferma: «Le 10 domande di Repubblica a Berlusconi erano lecite»
Le 10 domande di Repubblica a Berlusconi erano lecite, fondate su fatti veri e motivate dal pubblico interesse dei cittadini. Lo ha confermato la Corte d’appello di Roma dando ragione al quotidiano all’epoca diretto da Ezio Mauro. L’allora premier aveva chiesto un milione di euro di danni per la pubblicazione «reiterata e ossessiva» delle 10 domande e per un articolo del collega Giampiero Martinotti.
I fatti risalgono al 2009. Giuseppe D'Avanzo, su Repubblica, pone all'allora premier le famose 10 domande sui casi Noemi e Ruby. Il quotidiano del gruppo L’Espresso aveva da poco pubblicato gli articoli sulla presenza di Berlusconi al compleanno della diciottenne Noemi Letizia, la lettera dell’allora moglie del premier, Veronica Lario, i casi Ruby e D’Addario.
Quelle 10 domande, scrivono i giudici romani, «non erano spuntate dal nulla, ma nascevano da avvenimenti assolutamente veri che rendevano leciti i dubbi alla base delle stesse domande». Un contesto che «abilitava qualsiasi giornalista, soprattutto se dedito alla cronaca politica, a formulare al primo ministro i quesiti in questione».
E rigettando la richiesta di danni avanzata dai legali di Berlusconi, la Corte, confermando il giudizio di primo grado, ribadisce: «È lecito che una testata giornalistica reiteri domande su circostanze di grande importanza anche politica sul personaggio che guida la nazione».
Le 10 domande a Berlusconi, una pagina di buon giornalismo
di Raffaele Lorusso
La sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha confermato il rigetto del ricorso di Silvio Berlusconi contro Repubblica per le dieci domande che gli vennero rivolte con insistenza nei giorni degli scandali a sfondo sessuale in cui fu coinvolto l’ex premier rafforza il diritto di cronaca. E manda un messaggio chiaro ai professionisti delle querele e delle azioni temerarie: in presenza di un interesse pubblico alla conoscenza di determinati fatti è lecito, anzi doveroso, che un giornalista rivolga domande e pubblichi notizie con dovizia di particolari.
La tesi dei legali dell’ex premier, secondo cui quelle domande erano "capziose e suggestive", è stata smontata dai giudici della Corte d’Appello di Roma con motivazioni che ribadiscono il rilievo costituzionale del dovere dei giornalisti di informare e del diritto dei cittadini ad essere informati. Non v’era alcun dubbio già nei giorni degli scandali – e la sentenza della Corte d’Appello di Roma ne è ora la conferma – che quelle dieci domande all’ex premier, formulate dal compianto Giuseppe D’Avanzo, fossero dettate dal dovere deontologico di mettere l’opinione pubblica nelle condizioni di fare chiarezza sui comportamenti dell’allora capo del governo (non un cittadino qualunque) e sulle possibili ricadute di quegli atti sull’azione dell’esecutivo e sull’immagine del nostro Paese.
Conoscere fatti, circostanze e situazioni era infatti un passaggio essenziale per consentire ai cittadini di formarsi un’opinione e di essere in grado di esercitare, attraverso il suffragio universale, quella sovranità che viene loro assegnata dalla Costituzione.
Altro che campagna mediatica. L’insistenza con cui l’allora direttore di Repubblica, Ezio Mauro, ripropose quelle domande, alle quali l’ex premier si sottrasse, fu una pagina di buon giornalismo perché finalizzato a tutelare il diritto dei cittadini ad essere informati.
Indipendentemente dalla possibilità che l’ex Cavaliere faccia ricorso in Cassazione, i principi affermati dai giudici della Corte d’Appello di Roma sono destinati a fare giurisprudenza. Innanzitutto perché nella sentenza si dice chiaramente che il diritto dei giornalisti di informare e il diritto dei cittadini ad essere informati sono pilastri di ogni democrazia e – in presenza di un interesse pubblico alla conoscenza- prevalgono anche sul diritto alla privacy, soprattutto se ad essere coinvolti sono personaggi pubblici.
Ugualmente rilevante è il messaggio che viene mandato a chi crede di poter intimidire giornalisti ed editori con richieste di risarcimento danni milionarie. Berlusconi aveva chiesto a Repubblica un milione di euro. I giudici gli hanno dato torto.
Il passaggio necessario per chiudere il cerchio sarebbe dovuto essere – in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo - la condanna di chi ha promosso l’azione rivelatasi temeraria ad una sanzione pecuniaria proporzionale all’entità del risarcimento richiesto. La mancanza di una norma ad hoc continua a favorire i professionisti della querela perché questi ultimi sanno di non rischiare praticamente nulla.
È un vuoto normativo che – come la Federazione nazionale della Stampa italiana chiede da tempo – il Parlamento deve colmare al più presto.
Da Articolo21.org